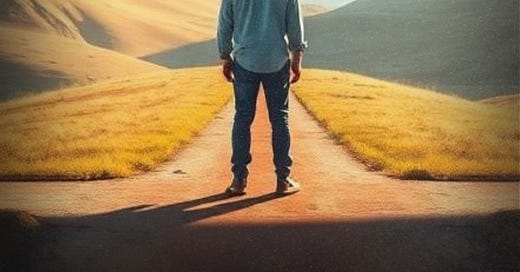Perché NON credo nel Libero Arbitrio: cosa significa essere Liberi?
Il libero arbitrio è un concetto complicato che ha avuto grande fortuna. Però, io non ci credo, e oggi vorrei spiegare perché: tra Agostino, Spinoza e il paradosso della scelta.
Attenzione: la trascrizione è gestita da IA e potrebbe non corrispondere completamente alla puntata relativa; potresti trovare degli errori. Dalla puntata del 7 maggio 2025.
Capitoli e argomenti
Libero arbitrio
Il libero arbitrio è la concezione che l'essere umano abbia la capacità di compiere scelte autonome, indipendentemente dalle determinazioni divine, cosmiche, genetiche o culturali.
Punti chiave
Il libero arbitrio è stato un veicolo di affermazione dei monoteismi, in particolare del cristianesimo, che ha promosso l’idea di un’anima individuale capace di scegliere liberamente tra bene e male, anche contro la volontà divina.
Permette all'essere umano di distaccarsi dall'idea di predestinazione, offrendo una risposta all’angoscia di sentirsi in balia di forze incontrollabili.
È una reazione all'angoscia della predeterminazione, tipica del pensiero antico e delle religioni politeiste.
La diffusione del libero arbitrio è legata al bisogno umano di sentirsi artefici del proprio destino, soprattutto nel passaggio dai politeismi ai monoteismi.
Spiegazione
Il libero arbitrio è visto come un distacco dalle concatenazioni e dalle determinazioni, permettendo all'essere umano di considerarsi padrone del proprio destino. Tuttavia, questa concezione può portare a nevrosi e ansia, poiché l'individuo si trova di fronte a infinite possibilità senza avere un vero aggancio. L’idea di libero arbitrio è considerata contraddittoria in un mondo determinato da cause genetiche, culturali e cosmiche, e la sua affermazione storica è stata una risposta all’angoscia della predestinazione.
Considerazioni
Il libero arbitrio è contraddittorio in un mondo predeterminato, sia dal punto di vista scientifico (fisica, neurologia) sia teologico (onniscienza divina).
La fisica e la neurologia suggeriscono che gli eventi sono determinati da cause più vaste rispetto alla volontà individuale.
Il libero arbitrio, invece di liberare, può generare ansia e paralisi decisionale, come illustrato dalla metafora dell’asino di Buridano.
Determinismo
Il determinismo è la teoria secondo cui ogni evento, inclusa l'azione umana, è determinato da cause precedenti, siano esse naturali, genetiche, culturali o cosmiche.
Punti chiave
Il pensiero antico, come quello di Eraclito e Parmenide, era fortemente determinista: tutto è frutto di concatenazioni di cause e non esisteva il concetto di libero arbitrio.
Il determinismo implica che le scelte siano già predeterminate, spesso molto prima che l’individuo ne sia consapevole.
Anche Platone, pur introducendo elementi nuovi, rimane legato a una visione determinista.
Spiegazione
Il determinismo sostiene che le azioni e gli eventi siano il risultato di una catena di cause ed effetti che si estende nel tempo e nello spazio. Questo concetto contrasta con l'idea di libero arbitrio, poiché implica che le scelte siano già state prese prima che l'individuo ne sia consapevole. La predeterminazione può essere angosciante per l’individuo moderno, che si trova a confrontarsi con la propria irrilevanza rispetto alle forze che lo hanno formato.
Considerazioni
Il determinismo è presente nel pensiero di Eraclito e Parmenide e in gran parte della filosofia antica.
La predeterminazione può essere fonte di angoscia e senso di impotenza, ma anche di consapevolezza e conoscenza.
Libertà secondo Spinoza e Agostino
La libertà non è intesa come libero arbitrio, ma come conoscenza e comprensione delle forze che ci determinano, e come agire in conformità con la propria natura.
Punti chiave
Spinoza: la libertà consiste nel pensare ciò che si vuole e nel dire ciò che si pensa, dove il “volere” è la manifestazione della propria natura profonda, non un desiderio arbitrario.
Agostino: “Ama e fa ciò che vuoi” significa agire in conformità con la propria areté (virtù), cioè con ciò che si è realmente, non secondo un arbitrio illimitato.
Entrambi rifiutano l’idea di un libero arbitrio assoluto, ma propongono una libertà fondata sulla conoscenza di sé e delle proprie determinazioni.
Spiegazione
Spinoza e Agostino vedono la libertà come la capacità di comprendere e agire in conformità con la propria natura e le forze che ci determinano, piuttosto che come la capacità di scegliere liberamente senza influenze. La vera libertà è la conoscenza delle proprie radici, dei propri limiti e delle proprie possibilità, non l’illusione di poter scegliere qualsiasi cosa.
Volontà come areté
La volontà è vista come virtù (areté), una spinta interiore che ci porta a progettare la nostra vita in base a ciò che siamo realmente.
Punti chiave
La volontà non è semplice desiderio o voglia, ma la manifestazione della nostra natura profonda, dei nostri talenti, paure e tendenze.
È la coscienza delle conseguenze primarie della nostra esistenza, il modo in cui le forze che ci determinano si esprimono in noi.
Spiegazione
La volontà, secondo Spinoza, è la consapevolezza di ciò che ci compone e ci determina. Non scegliamo i nostri geni, i nostri tratti caratteriali, le nostre passioni o malattie: li scopriamo. La libertà sta nel conoscere e accettare ciò che siamo, non nel credere di poter scegliere arbitrariamente chi diventare.
Libero arbitrio e nevrosi
Il libero arbitrio è visto come una fonte di nevrosi, poiché attribuisce un potere impossibile alla volontà umana e genera ansia di fronte a infinite possibilità.
Punti chiave
Il libero arbitrio ci rende nevrotici perché ci fa credere di avere un potere che non abbiamo realmente.
La libertà vera è nella conoscenza e comprensione di ciò che siamo e delle forze che ci determinano.
La società contemporanea, con la sua abbondanza di scelte (es. consumismo, streaming), amplifica la nevrosi da libertà, portando spesso all’immobilismo.
Spiegazione
Il libero arbitrio è criticato perché porta a sovrastimare la nostra esistenza e a vivere nell’ansia della scelta, mentre la vera libertà è nella conoscenza delle nostre determinazioni. La nevrosi contemporanea nasce dall’illusione di poter essere qualsiasi cosa, mentre in realtà siamo il risultato di processi profondi e spesso inconsapevoli.
Conoscenza come forma di libertà
La conoscenza è vista come la vera forma di libertà, non il libero arbitrio.
Punti chiave
La libertà è nella comprensione delle cause che ci determinano e nella capacità di dare significato a ciò che ci accade.
La conoscenza ci permette di vivere da protagonisti, non da vittime, accettando e valorizzando ciò che siamo.
Dare significato alla propria esistenza è l’atto di libertà più alto, come insegnano i filosofi antichi e moderni.
Spiegazione
La libertà è intesa come la capacità di comprendere e dare significato alla nostra esistenza, piuttosto che come la capacità di scegliere liberamente. Non scegliamo di nascere, di morire, di innamorarci o di convertirci: queste cose accadono e noi possiamo solo comprenderle e viverle pienamente. La conoscenza delle proprie radici e delle proprie determinazioni è la vera forma di libertà, che permette di desiderare ciò che si è, invece di inseguire illusioni di arbitrio assoluto.
Altri elementi rilevanti dal testo
Il percorso della Cogito Academy ha affrontato per un anno questi temi, e verrà rilanciato con un programma di storia della filosofia.
Nel libro “Dio era morto” dell’autore, vengono approfonditi questi argomenti, con particolare attenzione al passaggio dai politeismi ai monoteismi e alle conseguenze psicologiche della concezione di libertà.
La filosofia, secondo Hegel, arriva sempre “sul far della sera”: la comprensione giunge quando la realtà è già avvenuta, ma questo non la rende inutile, anzi, è ciò che ci permette di essere presenti e consapevoli.
La società contemporanea soffre di nevrosi legate all’illusione di libertà assoluta, che porta spesso a sentirsi vuoti e sradicati.
L’invito finale è a conoscere e desiderare ciò che si è, come forma più alta di libertà e di amore verso se stessi e la propria esistenza.
L'uomo è nato libero, ma ovunque è in catene. Con questa iconica constatazione si apre il contratto sociale di Jean Jacques Rousseau e nella sensazione di essere creature libere si è forgiato il nostro mondo. Ma siamo davvero certi di essere liberi? Siamo veramente liberi? Davvero possiamo pensare di emanciparci dalle molteplici cause che ci fanno esistere? Ecco, lo credo di no, ma la cosa è un po' più complessa di così.
Continua a leggere con una prova gratuita di 7 giorni
Iscriviti a Il Substack del Daily Cogito per continuare a leggere questo post e ottenere 7 giorni di accesso gratuito agli archivi completi dei post.